
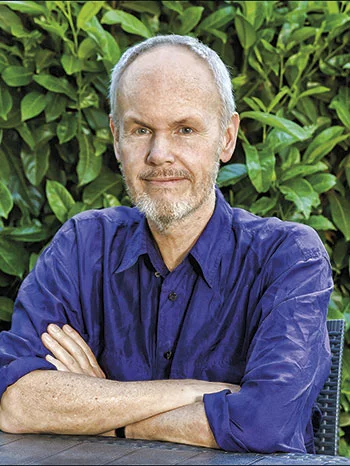
Non sono parenti, o almeno così parrebbe, anche se entrambi hanno origini irlandesi. Appartengono a epoche diverse, nati e vissuti in terre lontane, ma hanno lo stesso cognome, sono due grandissimi poeti animati da una profonda spiritualità e si somigliano persino fisicamente! In questo intensissimo testo, James scrive una lettera profonda e toccante al suo antenato poetico, Charles – che potrebbe essere anche un dialogo con sé stesso – ed ho pensato che, nel Giorno Internazionale della Poesia, non ci fosse nulla di più adatto a indicarne il ruolo di ponte fra tempi, luoghi ed anime. Un Poeta che parla con un altro Poeta nello spazio sublime e luminoso dello Spirito, dove il tempo non esiste e tutto è Uno.
Charles Harpur (1813 – 1868) nacque a Windsor, New South Wales in Australia, da una famiglia originaria della contea di Cork in Irlanda, uno dei primi europei a nascere in quel paese. Suo padre era maestro di scuola, ma Charles ebbe la fortuna di avere a disposizione la vasta biblioteca del governatore e di una ricca famiglia del luogo. Di cultura vastissima, ma quasi del tutto autodidatta negli studi superiori, fu autore copiosissimo di poesie di straordinaria bellezza e raffinatezza, sulle bellezze selvagge della natura, sul mondo aborigeno, sulla teoria poetica e la natura umana. Dopo una serie di lavori precari, collaborazioni con giornali e riviste e come insegnante e direttore di un ufficio postale, si dedicò all’agricoltura, ma fu anche nominato commissario delle attività estrattive dell’oro. La morte del secondo figlio, Charles, dovuta a un colpo di fucile partito accidentalmente a Charles Harpur, lo prostrò a tal punto che non si riprese più e infine si ammalò di tubercolosi. Durante la sua vita pubblicò molto poco dei suoi oltre 700 testi poetici, ma dalla fine del 19° secolo e a tutt’oggi è riconosciuto come il poeta nazionale australiano e la sua fama è in costante crescita. È possibile che vi siano dei lontani legami di parentela con James Harpur, che, con Charles condivide incredibilmente un’ispirazione poetica fortemente spirituale e, ancor più incredibilmente, una certa somiglianza fisica? Chi lo sa? Quel che è certo è il legame ben più saldo di quello del sangue che li unisce.
FRANCESCA DIANO
N.B. Le parti in corsivo nel testo sono citazioni di versi di Charles Harpur.
Ringrazio l’editore Andrea Molesini per il testo, che è parte dell’antologia della poesia di James Harpur, Il vento e la creta, a cura di Francesca Diano, Molesini Editore, 2024.
*************************************
Lettera a Charles Harpur
a Charles Harpur
Caro Charles,
non mi sono mai spinto fino a Singleton,
a Jerry’s Palins o ad Eurobodalla,
la tua fattoria sopra il viottolo rialzato
con cigli erbosi ed eucalipti;
la tua tomba, e quella di Charles, tuo figlio
insieme incorporate presso la casa colonica.
Windsor l’ho vista, e invano ho cercato
di immaginarti ragazzo
da quel tuo dagerrotipo seppia –
come un vecchio soldato confederato,
barba fluente, biancogrigia,
sguardo sinistro da profeta Elia.
Accanto, il tuo amico, il fiume Hawkesbury,
che si snoda fra campi autunnali;
ed Omero che bisbigliava tra gli alberi –
i versi che più amo furono anche tuoi:
Come la genia degli uomini è quella delle foglie
alcune il vento ha disperse a terra, mentre altre
ancora spuntano sui rami fruttiferi,
per fiorire nella loro stagione. Così degli uomini
muoiono e si rinnovano le generazioni.
Hai scritto che, dopo che le alluvioni distrussero
la tua fattoria, il primo attacco di TBC
e la morte di Charles ti stroncarono.
Poi scrivesti il tuo proprio necrologio:
Qui giace Charles Harpur,
che a cinquant’anni
giunse alla conclusione
di vivere in un’epoca fasulla,
sotto un Governo fasullo,
e fra amici fasulli,
e che qualunque altro Mondo
dovrà essere dunque
un mondo migliore del loro…
A malapena sopporto il pensiero
del tuo purgatorio prima della morte,
all’appassire del tuo errante cercare
di trarre la verità dalla poesia
in un coraggioso e nuovo New South Wales
edificato dalla gentaglia del Vecchio Mondo
e dalle fustigazioni quotidiane: non meraviglia che tu veleggiassi
verso la piana nerovino di Troia
smistando lettere all’ufficio postale
o passassi quegli anni ad allevare pecore
per ricavarti del tempo per scrivere, per poi affrontare
la croce delle lettere di rifiuto.
Cosa ti ha sostenuto? La fede? O il timore
di incontrare Milton nell’aldilà?
O il magico ingresso delle idee
che apparivano come le tue oche in volo
che seguono il serpeggiare della valle, eppure
s’allargano in lunghezza e in alcuni luoghi
spesso si staccano in punti solitari.
O t’han rapito gli occhi della tua Musa –
due mezzenotti di pensiero appassionato –
che nella mente ti hanno acceso immagini,
come quella del granchio sulla spiaggia, che attende
la sua preda fra le pietre lavate dall’onda
scintillanti al sole – e si accende di luce
quando si muove, quasi il suo guscio umido
andasse in fiamme.
I tuoi genitori t’han portato sradicato
in una terra di grog e marsupiali.
Hai mai chiesto a tuo padre, Joseph,
della sua infanzia a Kinsale?
O ti sei mai orientato con racconti
delle tue tradizioni familiari, quali quelle ch’io udii –
come, al seguito di Richard de Clare,
noi Harpur arrivammo a Wexford?
O del viaggio della bara di tuo padre
a solcare i mari del sud, per unirsi
alla tribù di Sisifo e forgiare
l’Ade agli antipodi della Britannia?
Ma tu, per i tuoi sogni condannato
ad essere il poeta laureato della tua nazione,
hai deportato te stesso in un regno
al di là delle Montagne Azzurre
ed hai scoperto… non la “Cina” –
lo Shangri-La delle fantasie dei deportati –
ma un cielo all’alba, alberi umidi di rugiada
e tutti luccicanti d’un velato argento;
o la sinuosa vallata delle acque;
o ampi ardenti campi, lieti di grano.
Sapevi che la natura ha una sorgente sacra
così come il sole è la fonte della luce
ed hai cercato di aprire gli occhi alla gente.
Ma non videro altro che un folle di Dio,
una voce che condannava nel deserto,
sacerdozi che restringono l’anima
incline al bere, all’autocommiserazione – ma che vedeva
in profondità nella vita delle cose:
e quel che è profondo è sacro, e deve tendere
a un qualche fine divino universale.
Fasulli l’epoca, il governo, gli amici –
qualunque luogo tranne Eurobodalla
ti parve una benedizione alla fine.
Immagino la scena sul tuo letto di morte,
la spettrale figura della Disperazione,
a testa china, fintamente afflitta;
ma anche Mary, seduta lì accanto
a ricordare il tuo corteggiamento; e scaffali
di pagine non lette, ibernate
come alberi d’inverno, per riaprirsi
in qualche luogo in una futura primavera,
di nuovo verdeggianti.
***********************
Letter to Charles Harpur
i.m. Charles Harpur (1813-68)
For Kevin Brophy and Penelope Buckley
Dear Charles,
I never got as far as Singleton,
Jerry’s Plains, or Eurobodalla,
your farm above the banked lane
of grassy verges and eucalyptus;
your grave, and that of Charles, your son
embedded by the farmhouse.
I did see Windsor, and tried in vain
to imagine you as a youngster
from your sepia daguerrotype –
like an old Confederate soldier,
waterfall beard, greyish white,
the baleful stare of Elijah.
Nearby, your friend, the Hawkesbury,
uncoiled through autumn fields;
and Homer was whispering in the trees –
my favourite lines were yours as well:
‘The race of men is as the race of leaves:
some the winds shed upon the ground, while still
the fructifying boughs put others forth,
to flourish in their season. So of men
the generations die and are renewed.’
You wrote that after floods ruined
your farm, the first flush of TB,
and Charles’s death had broken you.
Then came your self-obituary:
‘Here lies Charles Harpur,
who at fifty years of age
came to the conclusion,
that he was living in a sham age,
under a sham Government,
and amongst sham friends,
and that any World whatever
must therefore be
a better world than theirs …’
I can hardly bear to think about
your purgatory before death,
the fading of your errant quest
to wrestle poetry from truth
in a brave new New South Wales
constructed by Old World gentry
and daily floggings; no wonder you’d sail
to the wine-dark plain of Troy
as you sorted letters in a post office
or spent those years farming sheep
to scrape the time to write, then face
ordeal by rejection slip.
What kept you going? Faith? Or fear
of meeting Milton in the afterlife?
Or the magical ingress of ideas
appearing like your ducks in flight
following the windings of the vale, and still
enlarging lengthwise, and in places too
oft breaking off into solitary dots.
Or were you rapt by your Muse’s eyes –
two midnights of passionate thought –
igniting images in your mind,
such as your beach crab, who waits
for his prey amid the wave-washed stones
that glisten to the sun – gleaming himself
whenever he moves, as if his wetted shell
were breaking into flame.
Your parents brought you rootless
into a land of grog and marsupials.
Did you ever ask your father, Joseph,
about his childhood in Kinsale?
Or orientate yourself with stories
of family lore, like those I heard –
how, in the wake of Richard de Clare,
we Harpurs came to Wexford?
Or of your father’s coffin-voyage
across the southern seas, to join
the tribe of Sisyphus and forge
the down-Underworld of Britain?
But you, convicted of your dream
to be the laureate of your nation,
transported yourself to a realm
beyond the Blue Mountains
and discovered … not ‘China’ –
the Shangri-La of convict fantasies –
but a dawn sky, trees moist with dew
and glinting all with a dim silveriness;
or the sinuous valley of the waters;
or wide warm fields, glad with corn.
You knew that nature had a sacred source
even as a sunbeam’s fountain is the sun
and tried to open people’s eyes.
But all they saw was a fool of God,
a voice de-crying in the wilderness,
soul-dwarfing priesthoods
and prone to drink, self-pity – yet seeing
deep down into the life of things:
and what is deep is holy, and must tend
to some divinely universal end.
Sham age, government, friends –
anywhere but Eurobodalla
seemed a blessing in the end.
I picture your deathbed tableau,
the spectral figure of Despair,
head bowed, pretending to grieve;
but Mary, too, sitting there
recalling your courtship; and shelves
of unread pages, hibernating
like winter trees, to open
somewhere in a future spring,
in leaf again.
(C)2024 by Francesca Diano RIPRODUZIONE RISERVATA



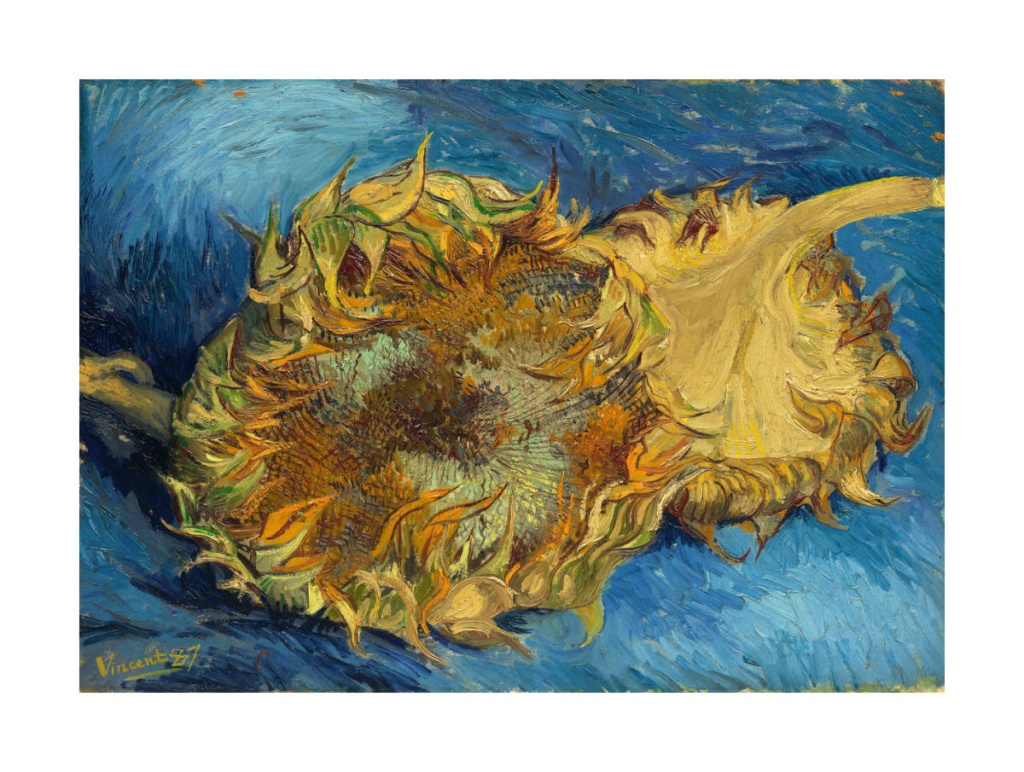



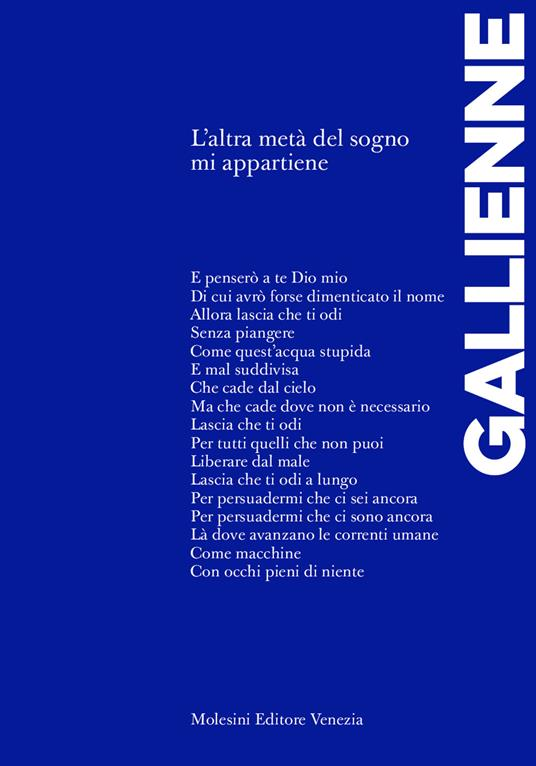












Commenti recenti